Dialoghi – Cina, cinema e gongfu
Marzo 2025
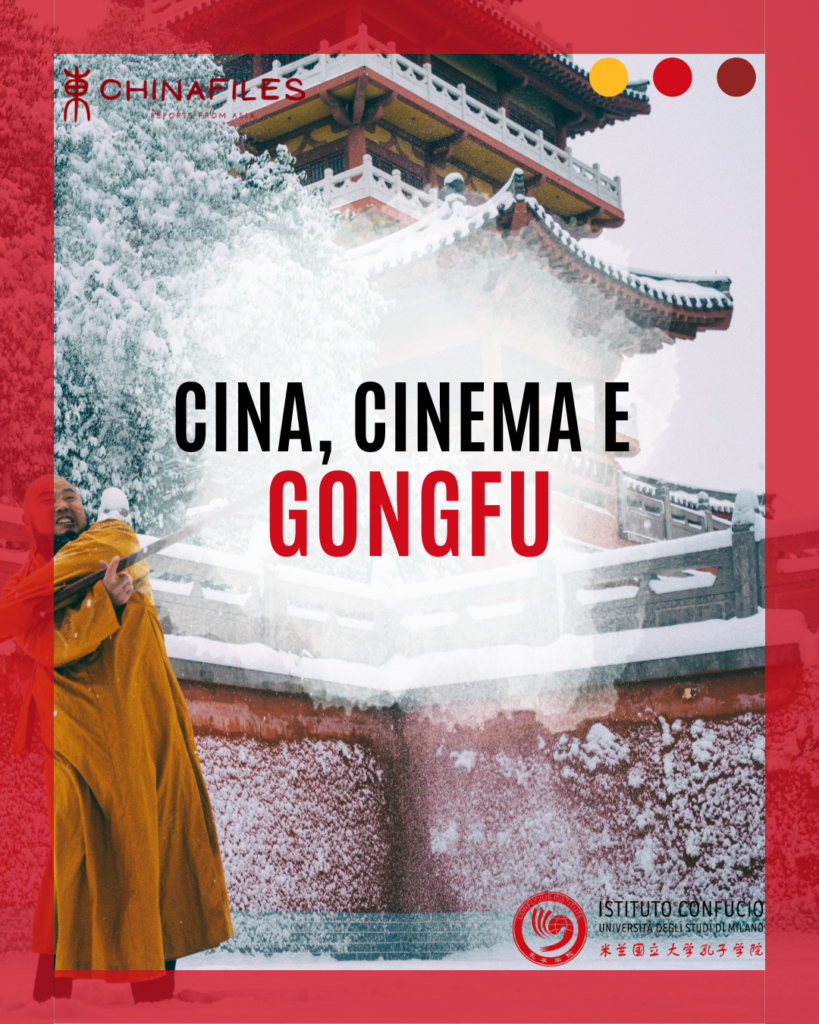
Le performance degli iconici marzialisti del cinema hanno appassionato intere generazioni rendendo le arti marziali uno degli elementi culturali cinesi più popolari al mondo. E che sembra non passare mai di moda, come dimostra il nuovo film di Mainetti nelle sale italiane in queste settimane. In patria e all’estero, il gongfu, o wushu, ha da sempre ricoperto un ruolo importante nella costruzione dell’identità nazionale della Repubblica popolare. “Dialoghi: Confucio e China Files” è una rubrica in collaborazione tra China Files e l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano.
Di Vittoria Mazzieri
Cina e arti marziali. Un connubio che negli anni Settanta del Novecento diventa un fenomeno pop globale grazie a film come I 3 dell’Operazione Drago e agli iconici combattimenti sul grande schermo di Bruce Lee, il sinoamericano artista marziale per eccellenza. Prima di quegli anni a Hollywood ci si riferisce a quell’insieme di pratiche utilizzando con un generico “boxe cinese”. Ma in breve tempo prenderà il via una vera e propria “mania del kung fu” e a inaugurarla è un film precedente, Five Fingers of Death: come capita ad altre produzioni del periodo, è un flop a Hong Kong e sbanca al botteghino statunitense. La star è la prima vera celebrità di kung fu, ancora prima di Lee: Lo Lieh.
Questo genere di film riesce ad attecchire facilmente tra i giovani emarginati e working class delle grandi città statunitensi: come scrivono gli autori di un lungo articolo sul tema, ad attrarre il pubblico è la capacità di raccontare le storie di eroi non bianchi, spesso con una vita difficile, che si scontrano con nemici, corrotti e sfruttatori con l’unica cosa che hanno e che possono controllare: il proprio corpo. Non a caso una ventina di anni più tardi il collettivo di rapper newyorkesi Wu-Tang Clan si richiamerà al kung fu come simbolo di rettitudine e lotta degli afroamericani per l’uguaglianza e la giustizia.
Ma dagli anni Settanta le interminabili scene di azione e le acrobazie sorprendenti piacciono davvero a tutti. In breve tempo le influenze delle arti marziali si estendono al cinema e alla televisione mainstream. Le grandi case di produzione occidentali esportano tecniche dalla tradizione cinematografica asiatica adattandole a un mercato che brama interminabili scene d’azione. Ma sarà alla fine degli anni Novanta che l’arrivo dei coreografi cinesi contribuirà ad affinare lo stile dei film prodotti negli Stati Uniti. È proprio la presenza di un coreografo esperto a determinare la buona riuscita di un film di arti marziali, a cui si richiede obbligatoriamente che i protagonisti siano marzialisti.
Un film italiano nelle sale in queste settimane vanta entrambi i requisiti. Si tratta di La città proibita, con cui il regista Gabriele Mainetti torna sul grande schermo a quattro anni da Freaks Out e a dieci da Lo chiamavano Jeeg Robot. I combattimenti di arti marziali sono stati coordinati da Liang Yang, stuntman e coreografo con esperienza hollywoodiana in film come Skyfall e Mission: Impossible – Fallout. La protagonista è la cinese Liu Yaxi, marzialista alla sua prima esperienza sul grande schermo a favor di telecamera ma con alle spalle lavori da stantwoman, tra cui come controfigura di Liu Yifei nel live-action di Mulan del 2020. Del regista Mainetti si sta parlando come del valido esponente di film di arti marziali che mancava all’Italia.
Il film propone un cast di volti noti, da Sabrina Ferilli a Marco Giallini, e una storia intricata che vede avvicendarsi lotte tra bande criminali e vicende di persone migranti e razzializzate nella Roma di Piazza Vittorio, considerata la chinatown della capitale. Mei, la protagonista, è per buona parte del film un personaggio misterioso e criptico, complice la barriera linguistica: è la seconda figlia di una famiglia della Cina rurale al tempo della politica del figlio unico ed è obbligata a nascondersi da occhi indiscreti che potrebbero denunciare la sua esistenza illegale. Sua sorella maggiore giunge a Roma per riuscire a racimolare i soldi necessari a pagare la multa che il governo cinese impone per “condonare” la sua nascita. Mei arriva in Italia proprio per cercarla, facendo quasi subito una scoperta tragica che darà il via all’intreccio narrativo. Come il suo personaggio, Liu Yaxi nasce nell’epoca della politica del figlio unico. Originaria dello Zhejiang, inizia a praticare le arti marziali per volontà del padre, fino a farle diventare un vero e proprio lavoro.
Gongfu e wushu
Parlare di arti marziali in Cina significa riferirsi a un centinaio di secolari stili di combattimento che incorporano filosofie e tradizioni cinesi. I termini utilizzate per indicare queste pratiche sono per lo più due: gongfu 功夫, da cui “kung fu”, parola onnicomprensiva per qualsiasi tipo di attività, e wushu 武术, che è invece più descrittivo e si traduce letteralmente come “arti/tecniche militari”.
Il nome suggerisce che siano nate come metodi di combattimento corpo a corpo tra i soldati, risalenti a migliaia di anni fa e rintracciabili in quasi tutte le epoche della storia cinese. La leggenda le vedrebbe nascere durante la dinasta Xia (2070-1600 a.C.), la prima dinastia descritta nelle cronache cinesi. La prima menzione delle arti marziali si registra negli Annali delle primavere e degli autunni (春秋, Chūnqiū), uno dei cinque classici della letteratura cinese risalente al V secolo a.C.
Le differenze tra le varie pratiche sono soprattutto su base geografica: i beipai 北派, gli stili della Cina settentrionale, incorporano calci ed elementi acrobatici, mentre i nanpai 南派, a sud, pongono maggiore enfasi sui movimenti delle braccia e del corpo. Uno degli schemi di classificazione più noti li separa tra stili esterni, waijiaquan, 外家拳, e interni, neijiaquan, 内家拳. Se i primi si concentrano sullo sviluppo di agilità e forza fisica, gli stili interni pongono l’attenzione sulla manipolazione dell’energia vitale, il qi (气 qì) e sulla coltivazione della mente e dello spirito.
Appartiene alla prima categoria la scuola Shaolin 少林, nata ai piedi delle montagne Songshan, nella provincia centrale dello Henan. Il tempio, meta turistica ormai da decenni, viene costruito nel 495 d.C. per permettere al monaco buddista Baotuo, proveniente dall’India, di predicare i suoi insegnamenti. Malgrado l’aspetto spirituale del buddismo Zen, lo stile Shaolin è incentrato sull’attacco e si distingue per i movimenti rapidi e vigorosi e l’utilizzo di armi (i più noti sono i bastoni). Secondo i registri storici, i monaci combattono a fianco dei Tang (618-907) aiutandoli a conquistare il trono, mentre sono arruolati in epoca Ming (1368-1644) per combattere i pirati che infestano le coste della Cina.
Un proverbio cita che “lo Shaolin è rispettato a nord e il Wudang a sud”. Dal nome della catena montuosa nella provincia dello Hubeu, lo stile Wudang nasce con la pratica taoista e in tarda epoca Qing (1644–1911) vanta una scuola a Nanjing, senza tuttavia ma riuscire a raggiungere la popolarità del gongfu Shaolin. Il Wudang è uno stile interno, dedicato alla coltivazione della forza interiore: il praticante colpisce solo dopo che il nemico ha fatto la prima mossa.
Il Wing Chun (Yongchun, 咏春) è una scuola relativamente giovane, che nasce nella Cina meridionale e viene perfezionata dal leggendario artista marziale Ip Man, originario del Guangdong e trasferitosi a Hong Kong da adolescente. Bruce Lee sarà un suo adepto. Vale la pena menzionare anche il Taiji o Tai Chi (Taijiquan 太极拳), che rientra nell’ambito delle pratiche Wudang: ad oggi è molto comune vedere anziani e non performare i suoi movimenti lenti e al contempo decisi nei parchi delle città cinesi.
Gongfu e identità
C’è chi sostiene che la distinzione tra stili “interni” ed “esterni” sia obsoleta, in quanto quasi ogni stile conta la compresenza di elementi di una e dell’altra categoria. Quello che è certo è che l’intrattenimento marziale, sia dal punto di vista folkloristico che soprattutto con il boom del cinema, ha preso la forma di una vera e propria “cultura delle arti marziali”, secondo la definizione utilizzata da Lu Zhaoxiang, professore associato della National University of Ireland Maynooth, nel suo saggio Politics and Identity in Chinese Martial Arts (Routledge, 2018). I film di kung fu derivano dai wuxia 武侠, i racconti fantasy della tradizione cinese che hanno come protagonisti eroi marzialisti e che diventano nel corso dei secoli un genere popolare a sé stante nella letteratura cinese, nelle produzioni teatrali e, infine, nella televisione e nel cinema.
La popolarità oltreoceano delle discipline di combattimento asiatiche in generale ha fatto sì che diventassero centrali nella costruzione dell’identità nazionale: dopo il Giappone, anche la Corea del Sud ha promosso la “diplomazia del taekwondo” come parte della sua campagna di costruzione di un’identità ufficiale. Sulla scia dei successi cinematografici anche la Cina ha avviato programmi di sensibilizzazione dedicati allo sport, allo scopo di promuovere l’immaginario che si lega alle pratiche del gongfu e del taijiquan, percepito dal pubblico occidentale come positivo e vicino al proprio sistema di valori.
“Il viaggio attraverso l’eredità cinese delle arti marziali ci fa capire che [..] i valori chiave insiti nelle arti marziali vanno dalla perseveranza, alla lealtà, al rispetto, [..] all’identità [..] all’armonia con la natura”, scrive un regista documentarista che lavora in Cina in un articolopubblicato dal China Daily nel 2021, durante la prima presidenza Trump: ricordando il successo della “diplomazia del ping pong” degli anni Settanta, l’autore suggerisce che lo spirito di queste discipline può aiutare a migliorare il dialogo tra Pechino e Washington.